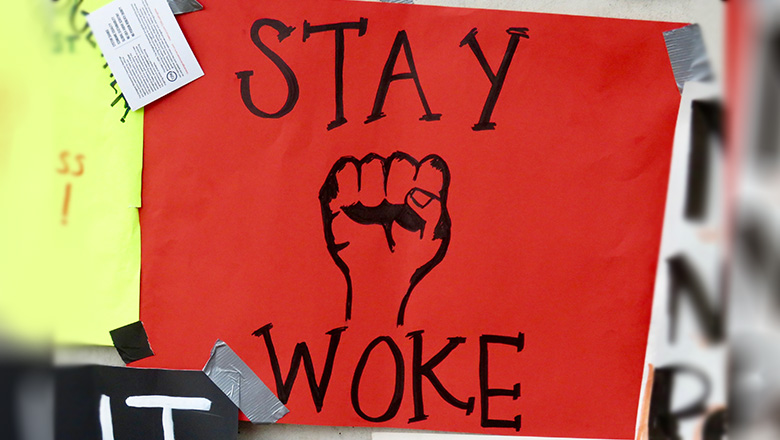I filosofi dietro il pensiero woke: radici critiche di un’ideologia contemporanea
Dall’economia alla cultura: l’eredità di Marx e della Scuola di Francoforte
Alla base del pensiero woke c’è una genealogia che affonda le radici nel Marxismo critico. Sebbene il woke moderno si concentri più su identità e cultura che su economia e classe, l’idea che la società sia strutturata da rapporti di potere che vanno smascherati nasce proprio da Karl Marx. La nozione di “coscienza critica” e la visione dialettica del conflitto sono i primi mattoni teorici.
Successivamente, la Scuola di Francoforte, con pensatori come Herbert Marcuse, elabora una critica culturale più sofisticata: non è solo il capitale a dominare, ma anche la cultura, i media, l’educazione. In L’uomo a una dimensione, Marcuse denuncia il conformismo delle società avanzate e invita a una radicalizzazione dell’immaginario — elemento centrale nelle attuali lotte woke.
Gramsci e il potere culturale: l’egemonia delle idee
Antonio Gramsci è fondamentale per comprendere la strategia culturale del pensiero woke. Con il concetto di egemonia, Gramsci spiega che il potere non si impone solo con la forza, ma si legittima nel senso comune: chi controlla la cultura, controlla la società. Da qui nasce l’idea che la trasformazione passi attraverso le istituzioni educative, linguistiche e simboliche.
Questo è il modello strategico che alimenta oggi il cosiddetto long march through the institutions, ovvero l’occupazione culturale di università, media e spazi simbolici per riscrivere le regole della rappresentazione.
Foucault, Derrida e la decostruzione delle verità
Nel secondo Novecento, il pensiero woke assorbe anche gli strumenti del post-strutturalismo francese. In particolare, Michel Foucault smonta il mito dell’oggettività: il sapere, dice, è sempre legato al potere. Le istituzioni — scuola, medicina, linguaggio — non sono neutrali, ma disciplinano i corpi e producono verità “normalizzanti”. L’identità non è fissa, ma costruita.
Jacques Derrida, con la sua decostruzione, mette in crisi ogni opposizione binaria (uomo/donna, razionale/emotivo, bianco/nero) e rivela il carattere gerarchico del linguaggio stesso. Questo porta alla messa in discussione delle categorie fondanti della modernità, elemento centrale nelle lotte woke contro il patriarcato, il razzismo sistemico e l’eteronormatività.
Teoria decoloniale e multiculturalismo: Fanon, Said e Spivak
Il pensiero woke è anche un’eredità delle lotte post-coloniali. Frantz Fanon, in I dannati della terra, descrive la psicologia del colonizzato e l’alienazione profonda prodotta dall’oppressione culturale. La violenza non è solo fisica, ma anche epistemica: nega il diritto di parola, di immaginazione, di identità.
Edward Said, con Orientalism, mostra come l’Occidente abbia costruito l’immagine dell’“altro” per giustificare il dominio coloniale. Gayatri Spivak, nella scia di Derrida, introduce la domanda: può il subalterno parlare? La risposta woke è: sì, ma solo se prima si demoliscono i codici imposti dall’alto.
Judith Butler e la performatività del genere
Un capitolo a parte merita Judith Butler, tra le pensatrici più citate nelle correnti woke. In Gender Trouble, Butler sostiene che il genere non è un dato biologico ma un atto ripetuto, una performance. Questo implica che non esistano identità “naturali”, ma che ogni ruolo sociale sia costruito e, quindi, decostruibile.
Da qui discende l’idea che l’identità sia fluida, soggettiva, autodeterminata — ed è su questa base che si fondano molte battaglie per il riconoscimento delle identità non binarie, trans, queer.
La pedagogia della liberazione: Freire e l’educazione come risveglio
Infine, Paulo Freire, con Pedagogia degli oppressi, ha fornito al pensiero woke la sua base educativa: l’idea che la conoscenza non sia trasmissione passiva, ma presa di coscienza critica, liberazione, dialogo. L’educazione, per Freire, deve aiutare i soggetti a leggere il mondo e a trasformarlo. È esattamente ciò che le pratiche woke cercano nelle scuole e nelle università: formare coscienze politiche.
Conclusione: una genealogia trasversale, un progetto politico
Il pensiero woke non nasce dal nulla, né è solo un fenomeno di costume. È l’esito di decenni di riflessione filosofica e politica sulla giustizia, il potere, il linguaggio e l’identità.
Dalle basi marxiste, passando per la decostruzione postmoderna, fino alla critica decoloniale e di genere, il progetto woke mira a smantellare le strutture profonde che producono esclusione e disuguaglianza.
Amato da alcuni, odiato da altri, il woke è oggi la più potente macchina critica del discorso occidentale. Comprenderne le radici è essenziale per affrontarlo, criticarlo o difenderlo con serietà.
Riepilogo dei principali contributi
| Filosofo / Scuola | Contributo al “woke” |
|---|---|
| Marx / Lukács | Base critica economica e di classe |
| Francoforte (Marcuse) | Critica culturale e resistenza simbolica |
| Gramsci | Trasformazione culturale attraverso le istituzioni |
| Fanon / Said / Spivak | Decostruzione coloniale e narrazione postcoloniale |
| Foucault / Derrida | Analisi di potere, sapere, identità |
| Althusser / Bourdieu | Educazione ideologica e disuguaglianza simbolica |
| Butler | Genere come performance e riconoscimento |
| Freire | Educazione critica e emancipazione |